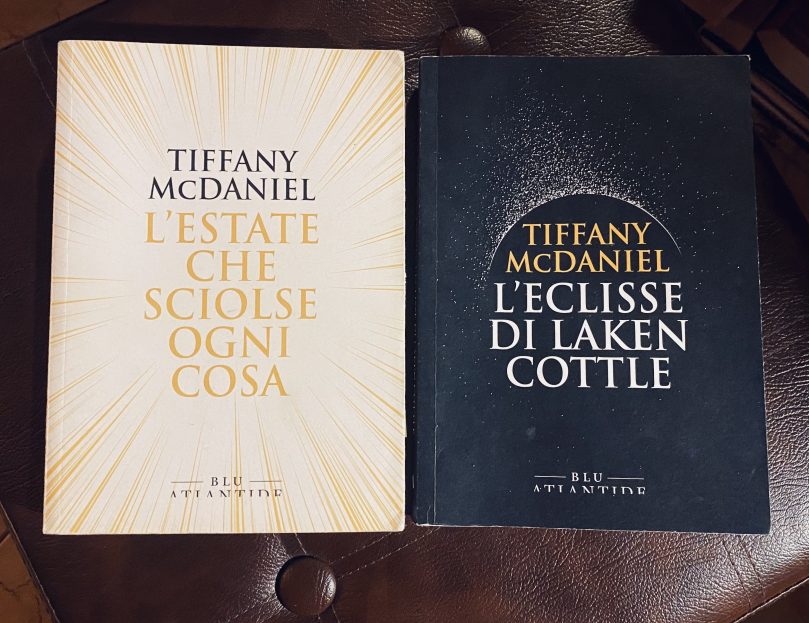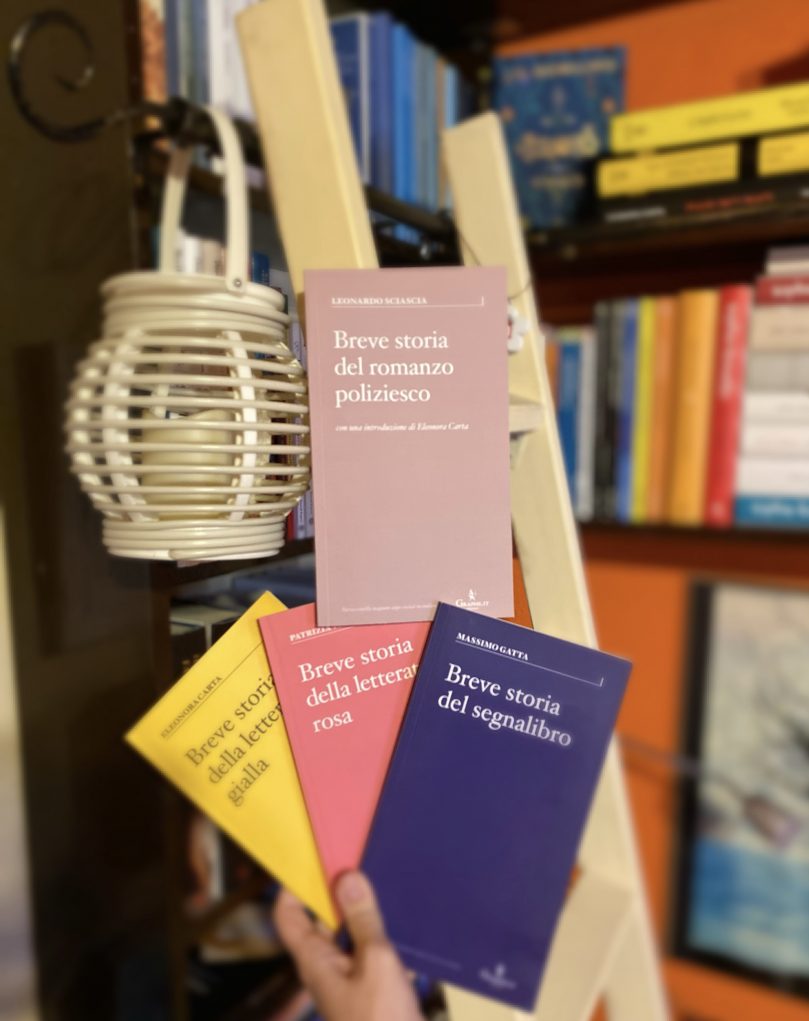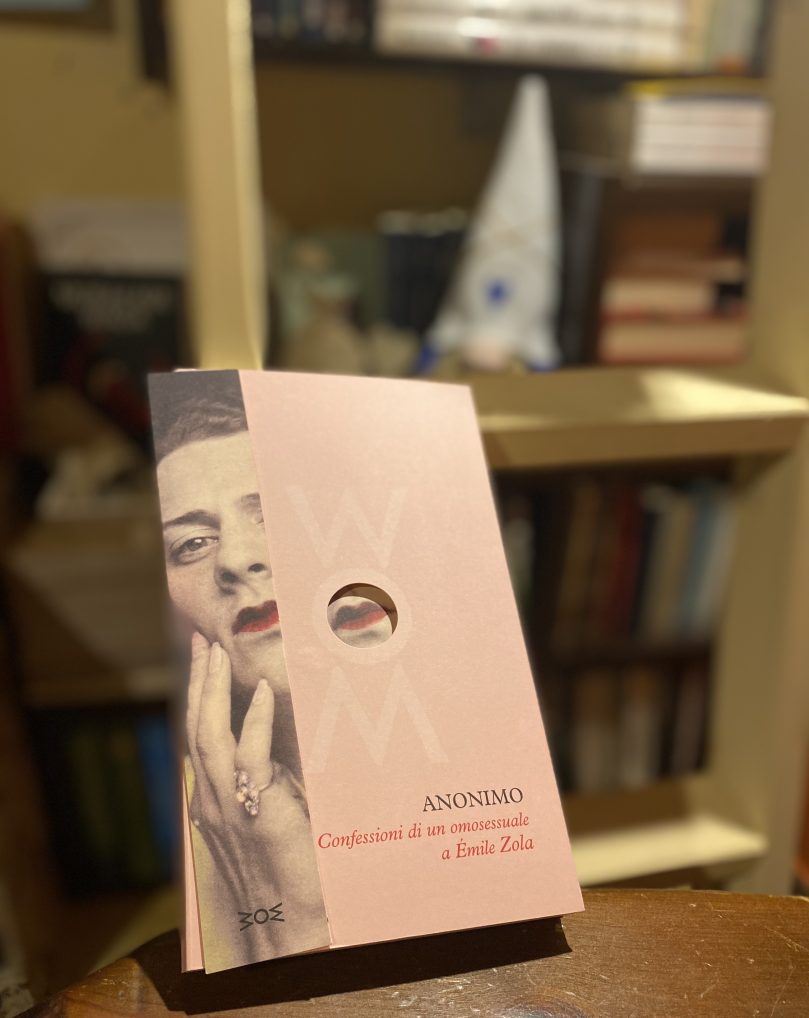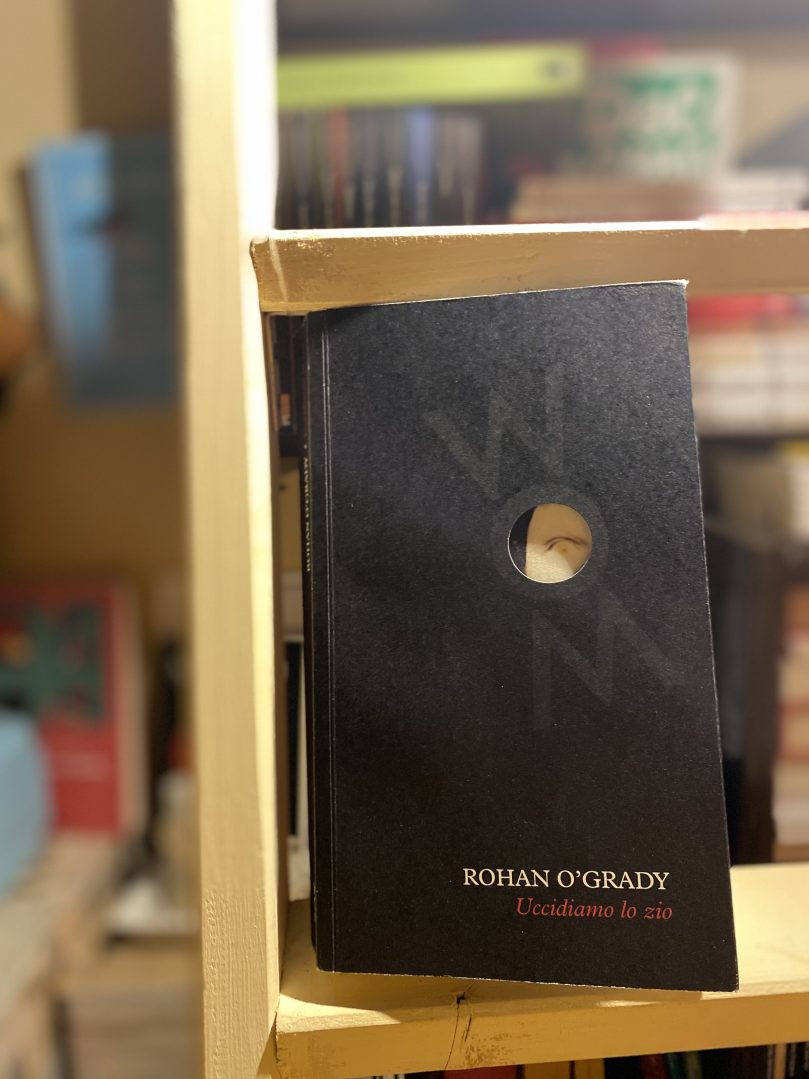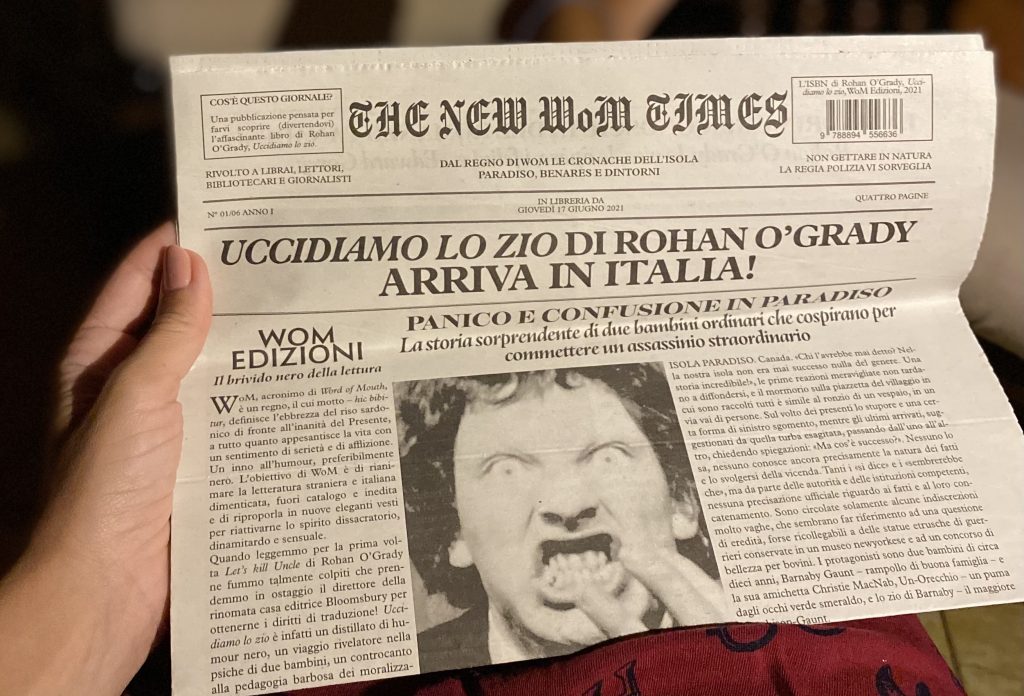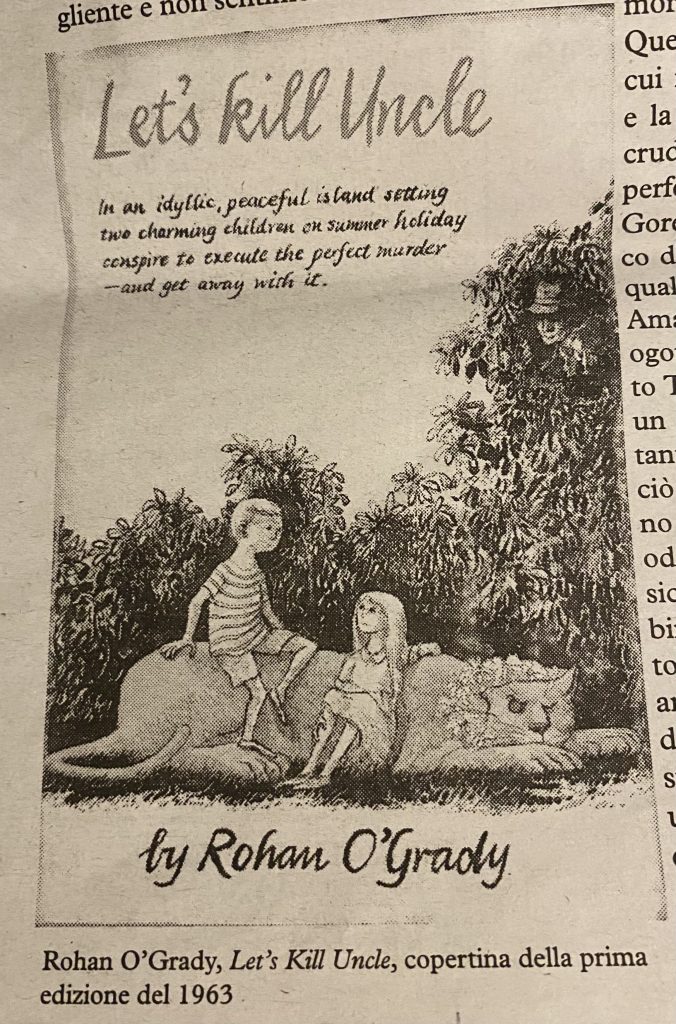“Della Sardegna è facile amare il mare, i suoi colori: sono talmente potenti da non poterli ignorare. Quello che è difficile scoprire è la sua gente. I sardi parlano una lingua unica, sono orgogliosi e testardi, ironici e fatalisti, con un’innata cortesia che scalda il cuore. La loro storia antica ce l’hanno scavata dentro, come solchi di una montagna.”
Nel giugno del 2019 leggevo Flavia’s end, sprofondata nella mia seggiolina sulla sabbia e nella storia, imbastita da Claudia Aloisi.
Leggevo di Flavia, Luigi, Maria, Estelle e Marco. Leggevo di blu cobalto del mare mentre il mare mi teneva compagnia.
Era stato come conoscere la mia terra per la prima volta, con i miei stessi occhi posati però sulle strade, sulle pietre e sui tramonti con il filtro delle pagine scritte da Claudia.
Questo Natale ho scartato un dono che mi ha fatto brillare gli occhi di urgenza.
Con i libri, succede molto spesso. Con quelli desiderati, anche di più.
“Eccola, la sua amata baia: il mare sempre di un tono più intenso del cielo, i monti di Nebida, protesi sull’acqua; le case aggrappata alle rocce nel loro incerto equilibrio, la familiare sagoma della torretta di Porto Flavia, invisibile a tutti, tranne a chi sapeva dove guardare. E poi lui, il Pan di Zucchero: il maestoso faraglione di calcare bianco striato dall’erosione, che si ergeva dal mare con la sua forma irregolare ma inconfondibile. Quello era il panorama che scandiva il tempo a Nebida […]”
Controluce. Claudia Aloisi.
Incredibilmente, a pagina 48, ero già consapevole di cosa avrei detto o meglio, scritto, alla fine.
Perché la sensazione è arrivata chiara e limpida lasciandomi certa che sarebbe perdurata fino all’ultima riga.
È stato come tornare a casa, senza essere mai andata via, eccetto qualche meravigliosa incursione di mondo là fuori.
Estelle Moreau, fotografa belga, si trova suo malgrado a ripercorrere i passi su quella terra che già una volta l’aveva accolta e sconvolta.
Tra i misteriosi eventi che collegano di nuovo passato e presente in un gioco di luci e ombre, il profumo salato dell’acqua di mare, il cielo “azzurro di smalto” rischiarato dal maestrale, e il gusto morbido di mandorle e arancia dei guefus, Estelle si interroga ancora una volta su cosa voglia davvero. Non è la sola a doverci fare i conti.
Domandarlo non è difficile.
Complicato è semmai trovare le risposte, nascoste in fondo a strati e strati di roccia.
Controluce non racconta soltanto una storia avvincente.
Ne racconta due: quella degli anni 20 del 1900 e quella degli anni 20 del 2000.
Ne racconta molte di più.
Perché ogni personaggio è un po’ come Shreck spiega a Ciuchino nel primo film d’animazione che li vede protagonisti: strati!
Le persone sono fatte di strati. Che siano più simili a cipolle o a torte, questo è tutto da scoprire.
Ma fa sempre riflettere l’evidenza, che ogni tanto scordiamo, che luci e ombre possano convivere dentro un’unica anima.
Quanto ai luoghi, l’urgenza di leggere si accompagna all’urgenza di andare a vederli.
Di nuovo, ancora e sempre, con quella suggestione in più che da i brividi.
La fantasia, si mischia alla realtà nell’ultimo giorno dell’anno, un giorno di sole.
La presenza del passato, tangibile anche se assente.
E basta un libro a evocare tutto questo.
A schiarire un po’ la vista, dopo che era stata abituata a parecchio buio.
La magia come risultato di un lungo lavoro di immaginazione, pazienza, fatica e passione.
Che meraviglia scrivere! E che meraviglia leggere!
Ed emozionarsi sulla pelle, quando per uno strano effetto, sembra di scorgere qualcosa all’imboccatura di una galleria, controluce.